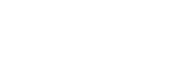Nonostante i tragici danni causati a tutto il mondo, la pandemia ha il merito di avere provocato un mutamento positivo per l’economia dell’Unione europea.
La politica economica richiede che si rianimi la propensione all’investimento delle imprese italiane
A cura di Leonello Tronti
Nonostante i tragici danni causati a tutto il mondo, la pandemia ha il merito di avere provocato un mutamento positivo per l’economia dell’Unione europea. Oltre a suscitare un nuovo spirito di solidarietà tra i paesi membri, concretizzato nel vasto programma di acquisti di titoli pubblici della BCE e nell’emissione di eurobond per finanziare prestiti e sussidi ai paesi più in difficoltà, è stato per il momento accantonato il Fiscal compact, la base dell’annuale verifica da parte della Commissione europea e del Consiglio dell’Unione del bilancio pubblico e del rapporto debito-Pil dei paesi membri. In questo modo è venuta temporaneamente meno quella vera e propria ossessione sul livello del debito che ha caratterizzato il “discorso sull’economia” dell’ultimo decennio, impedendo ai paesi ad alto indebitamento come l’Italia di varare le misure anticicliche indispensabili per riavviare la crescita in una fase di crisi. In realtà già prima della pandemia, il 27 novembre 2018, grazie anche al parere congiunto di Camera e Senato italiani e alle sollecitazioni di un appello internazionale di economisti lanciato dall’Italia, il Parlamento europeo aveva rifiutato di canonizzare il Fiscal compact all’interno dei Trattati e respinto la proposta di Juncker di farne una Direttiva europea. Ma per Commissione e Consiglio le cose erano andate avanti senza ripensamenti, esattamente come prima. Ora però la situazione è cambiata; il Fiscal compact è sospeso e bisogna pensare a come modificarlo prima di reintrodurlo quando la pandemia sarà superata. Olivier Blanchard, uno dei più autorevoli economisti europei, ha da poco pubblicato uno studio realizzato con Alvaro Leandro e Jeromin Zettelmeyer che propone di abbandonare del tutto il rigido sistema delle regole di bilancio europee per passare a regole flessibili, il cui unico obiettivo sia la sostenibilità del debito anziché il suo livello.
La pandemia ha il merito di avere provocato un mutamento positivo per l’economia dell’Unione europea. Il nuovo sistema flessibile potrebbe liberare gli investimenti pubblici e le politiche di domanda, sempre che gli effetti fossero tali da assicurare tassi di crescita monetari superiori agli interessi sul debito. Certo, queste indicazioni sono ancora soltanto indicative, in quanto premature e comunque provenienti da una sede che, per quanto autorevole, è tecnica e non politica. Ma sono importanti perché si sommano a quelle recentemente avanzate da altri autori molto autorevoli come Summers, Fisher e lo stesso Draghi, che segnalano da tempo l’esaurirsi degli effetti delle politiche monetarie e la necessità che i governi adottino politiche di spesa espansive.
In estrema sintesi, assumendo la riduzione del rapporto debito-Pil come obiettivo centrale e imponendo pesanti vincoli alla spesa pubblica anche se diretta ad investimenti, istruzione, ricerca e innovazione, la politica economica europea pre-covid cercava di ridurre il rapporto dal lato del debito (numeratore), senza riconoscere che ciò che conta davvero per l’evoluzione del rapporto non è l’entità del numeratore ma i suoi effetti – di breve o di lungo periodo – sul Pil (denominatore). È questa infatti la caratteristica, che distingue, nelle parole del nuovo Presidente del Consiglio, il debito “buono” da quello “cattivo”: il debito buono finanzia impieghi che fanno crescere il Pil più del debito stesso, e con ciò accelera la crescita e riduce il rapporto, mentre il debito cattivo esercita sul Pil effetti economici di entità inferiore al costo del debito stesso (inclusi gli interessi), e quindi continua ad aumentare il rapporto. Sembra quasi incredibile, ma per molti, davvero troppi anni, il dibattito economico italiano ha trascurato questa semplice ma cruciale differenza, che chiama in causa il ruolo dello Stato, quanto meno nell’ambito della politica industriale e degli investimenti a sostegno della ricerca e dell’innovazione. E si è invece concentrato su come ridurre le tasse e la spesa pubblica nell’illusoria convinzione che l’austerità fiscale fosse di per sé espansiva, cioè che bastasse lasciare più risorse al mercato perché questo le investisse nel modo migliore, creando “magicamente” occupazione, innovazione, benessere e sviluppo economico.
L’abbandono dell’intervento pubblico era anche suggerito dall’idea che non ci fosse alcun bisogno di stimolare la domanda perché essa era assicurata dalla globalizzazione del commercio internazionale a cui si sommava, in Europa, la creazione del grande Mercato Unico. Come suggeriva uno studio dello stesso Blanchard e di Giavazzi, per sfruttare questa straordinaria opportunità era necessario liberalizzare il mercato del prodotto e flessibilizzare quello del lavoro: questo sarebbe bastato a raggiungere il livello di competitività, ovvero di qualità e prezzo dell’offerta di beni e servizi, necessario ad assicurare una fase di sviluppo trainata dalle esportazioni (exportled). Ma in Italia le riforme strutturali hanno funzionato poco e male perché sono state applicate “a senso unico” e senza un controllo intelligente dei loro risultati: la flessibilizzazione – e purtroppo anche precarizzazione – del mercato del lavoro è stata perseguita con tenacia assai maggiore e risultati assai più cospicui di quanto non sia avvenuto con il mercato del prodotto. Con qualche positiva eccezione (penso anzitutto alle “lenzuolate” di Bersani, il cui peso va però valutato a fronte di fenomeni come la strenua opposizione sociale all’applicazione della direttiva Bolkestein), le riforme italiane hanno flessibilizzato il mercato del lavoro in modo decisamente eccessivo rispetto al perseguimento di un obiettivo di massimo sviluppo. Le politiche del lavoro non possono essere più rilevanti di quelle industriali né da esse autonome, o addirittura di esse sostitutive. Il mercato del lavoro è stato abbondantemente flessibilizzato per un ventennio dalle successive riforme di Treu, Maroni, Sacconi, Fornero, RenziPoletti, mentre le regole del mercato del prodotto restavano più o meno immutate e il sistema produttivo si polverizzava. Dal 2014 la bilancia commerciale ha segnato attivi rilevanti, ma al contempo la domanda interna è stata fortemente penalizzata dal blocco dei salari reali e dai tagli alla spesa pubblica e la crescita è stata modestissima.
Un dato particolarmente allarmante è quello della comune tendenza prociclica alla riduzione degli investimenti sia pubblici sia privati in rapporto al valore aggiunto, con un più forte ridimensionamento di quelli pubblici. Nel caso del settore pubblico la riduzione è legata alle politiche di austerità che, in un paese caratterizzato da una spesa corrente elevata, hanno investito in misura crescente la spesa in conto capitale.
La politica economica richiede che si rianimi la propensione all’investimento delle imprese italiane Ma in quello del settore privato si riscontrano ragioni opposte: da un lato l’indebolimento della maggioranza delle imprese ad opera delle sfide tecnologiche, dell’apertura dei mercati globali e della moneta unica; ma dall’altro un ambiente interno particolarmente se non eccessivamente favorevole, non solo in termini di costo del denaro e del lavoro (diretto e indiretto), ma anche di politiche contributive e fiscali attuate da governi di varia coloritura politica. In questa situazione, malgrado le fortissime perturbazioni che attraversano il periodo, il saggio di profitto in rapporto al valore aggiunto si è dimostrato notevolmente stabile e resiliente. Nonostante ciò, dopo la “doppia crisi” (2008-2013) la scelta di reinvestire i profitti realizzati ha mostrato una significativa caduta. Il problema italiano che Draghi è chiamato a risolvere è dunque la bassa propensione delle imprese a reinvestire i profitti realizzati più che l’esaurimento delle opportunità di profitto che, al contrario, appaiono paradossalmente migliorate. La politica economica richiede che si rianimi la propensione all’investimento delle imprese italiane – un compito cruciale nella fase attuale di uscita dagli effetti economici della crisi pandemica.
Gli strumenti per ottenere questo risultato sono diversi, e il principale è quello degli investimenti pubblici. Tuttavia, per potenziare il sistema produttivo è necessario condurlo a un aggancio sicuro all’economia della conoscenza, attraverso un intervento pubblico mirato alla creazione di un vero e proprio Sistema nazionale dell’innovazione. Non la semplice proliferazione di istituzioni e centri di ricerca, pubblici e privati, che si occupino per statuto della creazione e diffusione della conoscenza, ma un vero e proprio sistema, non solo di livello nazionale ma articolato su territori, settori di attività e dimensioni di impresa. Un’organizzazione a rete di carattere pubblico (come nel caso tedesco) o trilaterale (come nel caso olandese), capace di raccogliere e trasferire a tutti gli stakeholder dati, informazione e conoscenza, coinvolgendo e facendo collaborare singole imprese, filiere, reti o gruppi di imprese con le parti sociali e con amministrazioni pubbliche, università, scuole tecniche ed enti di ricerca, istituzioni bancarie e finanziarie, su progetti coerenti di sviluppo territoriale, settoriale, di filiera e di rete. Il sistema nazionale dovrebbe attivare e fornire alle imprese servizi di consulenza, formazione e ricerca, innovazione tecnologica e produttiva, digitalizzazione dei processi, internazionalizzazione delle relazioni economiche, trasformazione ecologica di prodotti e processi produttivi.
Nel sistema andrebbero coinvolte, coordinate, messe in rete e valorizzate istituzioni che già esistono, come gli Enti bilaterali che presiedono alla formazione e alla previdenza integrativa, le diverse attività che fanno capo al programma Industria 4.0, le linee di intervento del Ministero dello sviluppo economico, gli enti di ricerca e le istituzioni finanziarie che lavorano alla definizione dei piani di sviluppo dei territori. Risultati rilevanti potrebbero venire dalla diffusione di una contrattazione collettiva settoriale e territoriale declinata nella direzione della concertazione e del coordinamento dello sviluppo. Ma il requisito fondamentale è che queste istituzioni, che almeno in parte già esistono, siano organizzate nell’ambito di un sistema unico e organico: un’istituzione reticolare complessa e interconnessa, impegnata a prendersi cura non di un solo problema o di un solo lato dello sviluppo ma, organicamente, dei diversi problemi che caratterizzano le singole imprese, i gruppi e le filiere, i territori e i settori. È questo il senso, questo il valore della ripresa e della diffusione nella fase attuale di nuove politiche di concertazione.